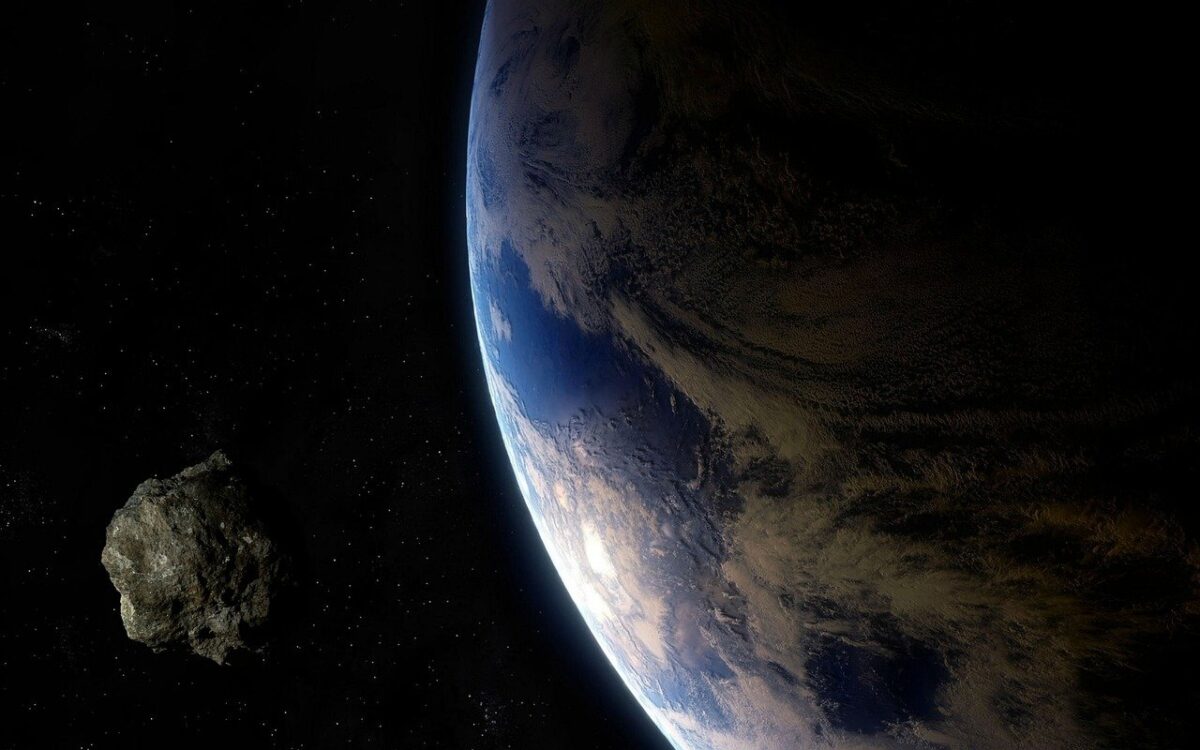Il corpo celeste si è disintegrato in due fasi a 28 km d’altitudine, rilasciando il 98% della massa in energia e detriti luminosi.

Il 13 febbraio 2023, alle 16:00 ora locale, un piccolo asteroide è entrato nell’atmosfera sopra il nord-ovest della Francia, generando uno spettacolare evento luminoso. Il corpo celeste, identificato come 2023 CX1, era stato avvistato solo sette ore prima da un astronomo ungherese, quando si trovava a circa 200.000 km dalla Terra. L’asteroide aveva un diametro inferiore al metro e una massa stimata attorno ai 650 kg.
Dopo l’avvistamento iniziale, NASA ed ESA hanno calcolato rapidamente il punto e l’ora dell’impatto atmosferico. A quel punto è entrata in azione la rete FRIPON/Vigie-Ciel, attiva in Francia per il monitoraggio dei bolidi atmosferici. Fondamentale è stato il coinvolgimento di astronomi dilettanti e cittadini comuni, che hanno condiviso immagini e video sui social, fornendo materiale prezioso per la ricostruzione dell’evento.
Un’esplosione in due fasi a 28 km di quota
Il video che mostra il momento esatto della disintegrazione del corpo celeste ha permesso agli esperti di studiare la dinamica della frammentazione. L’asteroide si è spezzato in due fasi distinte, a circa 28 chilometri d’altitudine, rilasciando il 98% della sua massa sotto forma di energia e detriti. La disgregazione è stata definita “molto violenta” dagli scienziati, una dinamica che può avere effetti significativi sulle onde d’urto prodotte nell’atmosfera.
Un confronto utile è con l’evento di Čeljabinsk (Russia, 2013), quando un asteroide simile esplose in aria causando danni estesi, pur senza impatto diretto con il suolo. In entrambi i casi, il comportamento esplosivo influisce sulla distribuzione dell’energia e può potenzialmente generare conseguenze più gravi rispetto a una frammentazione graduale.

Il recupero dei frammenti e il loro valore scientifico
Due giorni dopo l’impatto, è stato trovato il primo frammento nei pressi della comunità di Saint-Pierre-le-Viger, del peso di 93 grammi. In totale, sono state recuperate circa una dozzina di meteoriti, ora custodite dal Museo Nazionale di Storia Naturale francese. L’evento è stato documentato in uno studio pubblicato su Nature Astronomy e rappresenta un’occasione rara per la scienza: solo 11 asteroidi sono stati finora rilevati prima dell’impatto, e in soli 4 casi si sono recuperati frammenti.
L’analisi di questi campioni permette di indagare la composizione interna dell’asteroide madre, la sua struttura meccanica, la resistenza ai carichi atmosferici e le modalità di disgregazione. Il 2023 CX1, secondo le analisi, apparteneva con buona probabilità alla famiglia Massalia, situata nella fascia principale tra Marte e Giove.
Un modello per la difesa planetaria
Oltre al valore scientifico, il caso del 2023 CX1 offre indicazioni fondamentali per le strategie di difesa planetaria. Capire come e quando un asteroide si rompe entrando nell’atmosfera può fare la differenza nel valutare il rischio reale per la popolazione. Frammentazioni rapide e violente, come quella osservata in questo caso, possono generare onde d’urto più intense rispetto a una disgregazione più progressiva.
L’intero progetto dimostra anche quanto sia cruciale il contributo della citizen science. Video amatoriali, foto condivise online e osservazioni spontanee hanno reso possibile una copertura dettagliata dell’evento. La collaborazione tra scienziati, dilettanti e pubblico si conferma dunque un modello vincente per il monitoraggio dei fenomeni astronomici e per la raccolta di dati preziosi in tempo reale.